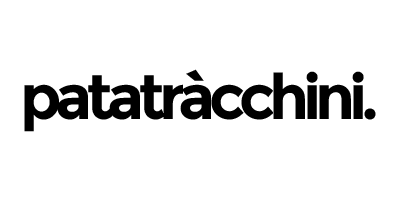24 Mar quattro.
Quattro sapeva coltivare la terra e farci crescere sopra degli animali del tipo proprio belli. Gli animali del tipo proprio belli avevano gli occhi strani color vuoto e non odoravano come quelli dei cartoni animati – ché poi come odoravano gli animali dei cartoni animati io non l’ho saputo mai, ma penso che fosse un qualche tipo di odore meno impegnativo di quello di questi animali cresciuti sopra alla terra – e a me mi facevano paura. Però, era una paura del tipo proprio bella pure quella e allora giocavo a toccarli, le ore. Quattro faceva l’elettricista. L’elettricista è un mestiere fondamentale giacché il mondo funziona quasi tutto con cose di tipo proprio elettrico – avevo letto su un libro che pure le persone, alla fine, funzionano grazie all’elettricità, e perciò Quattro mi è sempre sembrato un tipo importante: metti che qualcosa non funzionava dentro di me a livello di elettricità, era meglio tenerselo vicino, ché magari lui poteva aprire e scoprire cosa non andava e sistemarlo con il nastro isolante. Quattro, infatti, era molto portato per la materia “cose che non funzionavano”: sapeva sempre dove cercare e dopo che cercava, era anche molto portato per il trovare e dopo che aveva trovato, Quattro il più delle volte gli dava di forbici e cacciavite, di fili di rame, di nastro isolante, e pazientemente aggiustava le cose. Anche le cose disperate aggiustava. Anzi, più la prova era una cosa del tipo impossibile, più la disperazione abitava gli oggetti – e pure le persone, penso io – e più Quattro si sedeva paziente a trovarci un significato, una speranza, un appiglio. E luce fu. Tutte le volte che Quattro toccava le cose, l’ombra si accendeva e uno, in generale, si sentiva meglio e aveva anche un po’ meno di paura. L’importante era non buttare via niente. Categorico, imperativo, assoluto. Qualsiasi cosa poteva essere riparata e riparata e ancora riparata, e di buttarla non se ne parlava nemmeno. Quattro, difatti, come hobby – senza sapere che si chiamasse così – teneva tante cose disordinatamente nascoste in armadi coi lucchetti. Quattro collezionava le cose. Tutte. Monete, schede telefoniche, penne, portadocumenti, portachiavi, agende delle banche, elastici scooby-doo, calendari, accendini, fucili, cani di nome Bobby, gilet verdi con le tasche, camicie di pile in varie fantasie, mocassini, pettini per capelli. Inoltre, Quattro in più aveva l’incomprensibile abitudine di segnare su un diarietto, tutti i santi giorni, il tempo del tipo proprio meteorologico che c’aveva sopra la testa. Qualsiasi cosa gli sia successa, ha sempre trovato un po’ di tempo – del tipo proprio quello che passa – per guardare il cielo e vedere come se la passava quel giorno. Alzava gli occhi, osservava, appuntava: “Pioggia”; “Sole con freddo”; “Neve”; “Sole”. Quando non gli riusciva di guardare il suo di cielo, si accontentava di guardare il cielo degli altri, ma stava bene attento a segnalarlo: “Sole (da casa di Centododici)”. Questo perché Quattro al suo cielo e alla sua terra ci teneva in una maniera del tipo tanto, e anche al suo tempo – del tipo che passa e del tipo che piove – mi pare evidente che ci stesse molto attento. Quattro ha avuto nell’ordine: una Fiat Centoventisei viola col portapacchi, una Fiat Uno bianca senza portapacchi, una Daewoo Matiz azzurra con il portapacchi, una Fiat Panda grigia con il portapacchi. Quattro penso che si sia perdonato parecchi dei suoi errori fatti nella vita, ma l’aver preferito – in una singola occasione – un’autovettura non italica a una italica, io penso veramente che non se lo sia perdonato mai. La Fiàt è la Fiàt. Quattro la chiamava con l’accento sbagliato, o comunque con l’accento del tipo Quattro. Comunque, le autovetture – così cronologicamente inventate – se gli venisse voglia di incontrarsi in un bar per bersi qualcosa assieme e ricordare un tempo del tipo proprio tempo bello del passato, io penso che tutte si ricorderebbero la stessa cosa. Più che altro d’aver subito negli anni, si ricorderebbero: la guida esasperante di Quattro, ignorante dell’esistenza di una marcia superiore alla seconda; le pallonate instancabili, cariche di palle e rabbie, che Tredici amava come un pazzo rivolgere loro in quello stile del tipo deliberatamente; la condizione di laboratorio ambulante carico di legno, fili elettrici, pezzi di ricambio per questo o quell’elettrodomestico, cacciaviti, cavi, martelli, trapani, componenti elettronici, citofoni, interruttori – singoli e multipli, nastro isolante. Riderebbero a crepapelle, quelle sceme di macchine. Ora, io penso che, in realtà, le macchine si ricorderebbero anche di tutte le volte che sono state usate per accompagnare per esempio Dodici e Tredici a fare cose in giro del tipo imparare delle cose e crescere veramente, ma questo racconto è un racconto che parla di Quattro e non di un aperitivo tra autovetture rottamate. Quattro io l’ho visto piangere un numero perfetto di volte. Cioè tre. Quando è morta Due. Quando una nidiata di piccoli pulcini spennati è morta di freddo. Quando ha deciso che quella cosa che stringeva tra le mani – una cosa che senza dubbio Quattro l’aveva amata più di tutte le altre – si poteva buttare, perché non valeva la pena aggiustarla. Quattro, poi, io l’ho visto ridere un numero perfetto di volte. Cioè sempre. Con quel sorriso bellissimo che muove gli occhi a fessura e spalanca un numero incredibile di denti bianchissimi. Un sorriso seducente e rumoroso che – l’ho capito solo adesso – era una cosa grande perché gli altri, non appena lo vedevano quel sorriso del tipo proprio Quattro, iniziavano a ridere pure loro – giù a ridere, come matti – senza capire, il più delle volte, il perché.
(Illustrazione di Risaoberry)