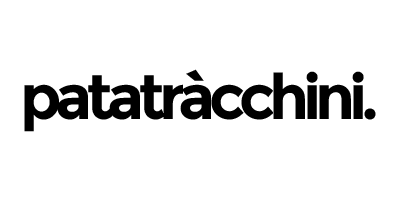24 Aug patria.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti?
(Konstantinos Kavafis)
Sono nato in un giorno di sole, mentre sulle colline fiorivano violenti i gigli bianchissimi e spuntavano, senza rimedio, cespugli odorosi di lavanda blu. Ho passato un’infanzia infelice, che è l’unico modo sensato di passare un’infanzia. Ho imparato la tua lingua, le tue regole, i tuoi ritmi sempre e per sempre in contrasto coi miei. Patria, ho scoperto la tua storia – quella eternamente scritta dai vincitori, mai dai vinti: notti taciturne studiando a memoria le tue date importanti; giorni d’inverno lunghissimi, e seduti composti, a celebrare le tue feste comandate, a mangiare i tuoi cibi sacri, a riposare: sognando la conquista dei tuoi segreti. Ero scontento sì, sempre, ma ero libero e abbozzavo su un quadernetto verde stringhe imprecise che mi raccontavano di me. Non ho conosciuto la noia. Ho dedicato il mio tempo a capire la tua geografia, a disegnare i tuoi bordi irragionevoli, poggiando il foglio bianco contro il vetro della finestra, in cucina. Della tua toponomastica ho fatto una sorta di religione sprovveduta, una religione in cui c’era, peraltro, un eccesso di Dio. Patria, ti ho dormito dentro per quello che adesso mi appare un tempo finito e incessante. Ti ho messo in dubbio con una costanza incostante, mai debole, eppure sempre arresa: mi eri ovvia come un cruciverba da risolvere dopo che qualcuno l’ha già risolto. Sono stato disteso sui tuoi campi collinari, sdraiato sui tuoi mari, ho camminato le tue strade, impervie verso cime di montagne silenziose. A vent’anni ti ho incontrata per quello che eri: ti ho guardata negli occhi affamato. Ho capito che la mia infanzia infelice stava di colpo diventando una giovinezza altrettanto sprovvista di allegria, e allora ho creduto solo in te e ti ho giurato fedeltà. Per sempre. Ho imparato i tuoi canti, inni di un’antichità sconfortante; i nomi dei tuoi poeti, l’onore dei tuoi morti, il coraggio dei tuoi vivi. In te ero nato, in te c’era stato il mio principio; in te sarebbe finita, presto o tardi, quella mia esistenza, che continuavo a segnare su quaderni sempre più grandi, sempre più colmi di sproloqui senza virgole, avendo io accumulato in me stesso una scarsa fiducia nella mia memoria. Ho lavorato per te, ore su ore, per capire, per inventare, per capire silenziosamente nascosto dentro le tue pieghe più profonde. La semplicità con cui iniziavo a rintracciare occasioni, la manifesta presenza di soluzioni suggeriva in modo lampante l’esistenza di problemi, di contraddizioni affascinanti ma insostenibili. Ne eri cosciente, Patria, e facevi del tuo umore un’altalena: alle spalle coltivavi l’abbandono – la tristissima resa verso la tua indole schifosa, ti facevi dura, ottusa, misera; verso il cielo speravi nel cambiamento, nella liberazione, accoglievi col sorriso il futuro che non arrivava mai, il progresso della tua emotività. Sono salito sulla tua giostra, ho sopportato gli arretramenti, segni sulle ginocchia, spalle indolenzite; ho avuto fede nelle tue evoluzioni, pancia piena e domeniche a letto fino a tardi. Mi sono stancato. La mia giovinezza disperata si faceva età adulta affranta, senza che io potessi in alcun modo prendere tempo. Con quello che restava della mia arroganza infantile, ho stretto i pugni nell’aria e ho fermato le tue corde. Ti ho parlato per amore, Patria, ti ho raccontato di quello che eri, ancora di più di quello che saresti potuta essere, di quanta bellezza in volo portavi, di quanto poco sarebbe bastato per fermare l’immobilità e andare davvero verso il domani. Non volevo che cambiassi, volevo che splendessi. Sei crollata in una follia sorda, sei scappata chiudendoti dentro i tuoi Palazzi, hai impedito la parola, hai bendato gli sguardi, ti sei fatta tempesta sacrificando anche te stessa per salvarti dalla provocazione, e mi hai lasciato solo con la mia tragedia. Non era il peggio, questo non potevo saperlo. Mi hai risposto con uomini vestiti di scuro, entrati a casa mia a notte fonda, che hanno riempito me di botte e la valigia con le mie poche cose. Mi hanno accompagnato alla Stazione, passando attraverso il bosco, dove il tuo odore regnava selvatico, e mangiava i miei polmoni per l’ultima volta. Sono diventato un nomade. Ho perso ogni diritto nei tuoi confronti, mi è rimasto solo un dovere: non tornare. Non sapevo dove mi trovavo: dormivo in letti sempre diversi e nessuno mai era il mio. I miei sogni erano ferite. Scrivevo solo lettere per te e le spedivo sperando come un pazzo che ti arrivassero, che le leggessi, immaginando fin nel dettaglio come avresti reagito, pregando il mio Dio che eri tu, pregandoti, affinché mi rispondessi. Pregandoti di venire a riprendermi. Non sei mai venuta, Patria. Mi hai abbandonato. Nel mio delirio di treni notturni e giornate spaventose, ero perso in fredde città sempre uguali: un esiliato a cui non è stato dato nemmeno il prestigio di un posto esotico da appuntare tra le righe della propria addolorata biografia. Mi ero chiuso in un silenzio disumano, mentre attorno a me estranei esaltati mi parlavano, in lingue sconosciute, di popoli di cui non mi importava niente. Erano dei fanatici della vitalità. Io volevo morire, ma non morivo. Dormivo appena, bevevo molto e mi costringevo a mangiare il loro pane, senza sapore per la mia bocca straniera, senza nutrimento per il mio ventre profugo. Ricevevo scarse notizie di te, Patria, ma erano le uniche a tenere ancora assieme il mondo. Qualche foto dai tuoi paesaggi generosi, qualche canzone dalle tue feste popolari. Non volevo, ma le parole di quella gente nuova mi entrarono nella lingua, si impadronirono del mio pensiero, parlavano in me. Scrivevo col tuo vocabolario, Patria, ma iniziavo a capirli e a rispondere. Non ereditai mai quel loro entusiasmo, ma mi stavo arrendendo ai loro modi, ai temi dei loro dibattiti serali, stavo accettando, sebbene il mio impegno quotidiano fosse solo il ricordo e la costruzione affannata del mio futuro nel passato. Volevo solo tornare a casa e tutto mi era sopportabile, tranne pensare che quella sarebbe stata la mia eternità. Sono passati tanti anni, accumulati come bugie di cui è difficile ritrovare l’inizio; ho conosciuto persone come me, persone diverse da me, ho ascoltato disgrazie indicibili e catastrofi senza catarsi. La mia età adulta tristissima e muta è proseguita insegnandomi la sola cosa che mi poteva insegnare: che si vive per abitudine e per nient’altro. Ho trascinato la mia anima apolide nei giorni, rivendicando il rispetto che si deve a chi vive di assenza. Non ho più sentito il bisogno di appartenere. C’ero e basta: un nessuno che non reclamava niente. Ho smesso di leggere i tuoi giornali, ho smesso di leggerli tutti, non volevo sapere; scrivevo di mondi altri dove non esistevano patrie, né regole, dove ero io a decidere dove stare e cosa dire. Mi nascondevo nei bar dove ambientavo le mie storie, nelle case che inventavo per i miei personaggi, sullo sfondo delle mie realtà surreali: ero diventato un rifugiato politico della mia fantasia. In quel regno ci passavo quasi tutto il tempo e non speravo altro che di essere lasciato in pace. Questo universo era il mio universo e lo abitavo, ormai con grazia, al riparo dal tuo ricordo. Senza accorgermene, l’adulto angosciato che ero stava diventando un vecchio quieto, che imparava con calma a non scagliare il suo dolore sugli altri per il semplice fatto di averlo sempre fra le mani. Stavo imparando a poggiarlo, il mio male, dopo avergli trovato un posto in quella che ormai mi scoprivo riuscire a chiamare casa. Non soffrivo più. Stavo dimenticando. Ti stavo dimenticando, Patria. E sarebbe potuta finire così, con la polvere del mio corpo cosparsa un pomeriggio di novembre sul pendio dolce di una collina straniera, dove la terra che sono sarebbe tornata semplicemente terra. Aspettavo quel momento con docile remissione, eppure mi è capitato di nuovo di interessarmi. Mentre passeggiavo, un giorno di inizio maggio, vidi una possibilità: riscoprii nell’aria il rumore di un’occasione. Seduto al caffè della piazza principale della città stava un altro vecchio, incontrai il suo sguardo, che pure aveva sentito chiaramente quell’odore di futuro. Non ci fu necessaria nemmeno una parola, e questo già faceva intuire che una patria non ha bisogno di una lingua, ma di una sensibilità comune. Non ci dicemmo niente, ma iniziammo a camminare nella stessa direzione, sentendo che quella terra sotto ai nostri piedi era la nostra terra e questo ci diceva anche che una patria è una cosa, senza confini, fatta per essere camminata finché non si sente che è il momento di fermarsi. Non esisteva un dentro o un fuori, nemmeno un vicino, figurarsi un lontano: esisteva solo uno stare dove qualcuno ti riconosce e si fa riconoscere senza fatica. Una patria è uno spazio di fiducia, non di fede: puoi restituirmi le mie preghiere, Patria, ne farò incipit di storie che finiscono bene. Storie piccole e di poco conto che si opporranno alla tua grande Storia, così davvero inutile visto che non insegna niente. Seguitammo a camminare, io e quell’altro, seguendo quel profumo di novità per le strade, quello straordinario così normale e leggero. Non riuscivamo a fermarci e non c’è verso di farlo neanche ora. Non ci fermeremo. Sorrido nel vederti adesso, più libera e serena, senza di me che con la mia voce ti ricordavo quanto potessi essere migliore: ero io che sbagliavo. Una patria non può essere migliore, noi possiamo esserlo, smettendo di accettare quello che sembra vero, rifiutandoci di farci tenere o di vederci allontanare, escludendoci per non farci escludere. Una patria non è una cosa che sta in alto: non bisogna vincere niente per conquistarla, né adorare chi si fa ritrarre in immagini trionfanti. Una patria è una cosa orizzontale fatta di almeno due persone che si somigliano solo per la loro voglia di avere un domani più bello di oggi.