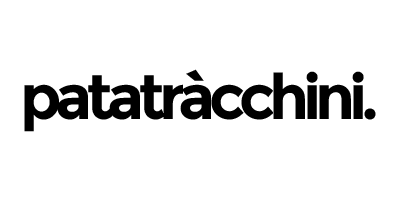(pubblicato su CheFare il 5 dicembre 2016)
In questi giorni, ritmati da un inverno (bi)polare e da questa scomposta invasione di sì e di no (più i no che i sì), legati a una sostanziale messa in discussione di una parte importante del nostro passato, mi è venuta voglia di rileggere uno dei libri che negli scorsi anni mi è stato più amico, Gli anni (L’orma), guarda caso, di Annie Ernaux.
Avendolo già letto, e avendo già infittito le pagine con sottolineature sbadate, macchie di caffè e appunti sconnessi, la lettura non andava cercando la bellezza puntuale, l’intuizione o la tecnica. Non cercava neanche la storia, ché la storia la sapevo già. Insomma, non c’era traccia nello scorrere delle pagine di attentati intellettuali, di approcci conosciuti. L’ho letto e basta.
Quello che cercavo era forse un significato, una ragione, un tratto comune che potesse far dedurre una traiettoria, una direzione, una spiegazione plausibile a quello che, passando da lì, siamo diventati oggi (si fa riferimento, per chi non avesse letto il libro, alla storia della generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale in età infantile). Tra le righe di simboli sociali usuali, di retorica post secondo conflitto mondiale, di emozioni di ragazza che c’era quando quel tempo passava, quello che più mi ha colpito è rintracciare, nemmeno tanto ai bordi, uno dei retaggi più potenti nonché, per certi versi, positivi e necessari, che ci siamo portati dietro negli ultimi duecento anni: l’istruzione.