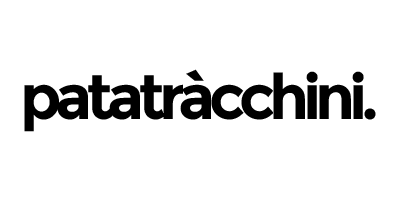22 Aug farewell.
Possiamo fare mezze maratone per raggiungere il tuo cuore irraggiungibile,
poi continuare a vivere e non avere niente da perdere.
(Vasco Brondi)
Tu respira con calma, bimba mia, con calma, perché quel respiro tuo è sempre stato l’indice che ha portato il segno dentro le pagine di un libro bellissimo; il respiro tuo lento, quel modo di prenderlo e tenerlo dentro, per quattro minuti secondi, prima di raccontarmi, alla sera, le tue cose incredibili.
E non ti tagliare i capelli – non lo fare – non ti tagliare i capelli mai più; ché ti assicuro, posso riuscire a farli rimanere come sono ora per il resto del tempo, ci posso riuscire, fidati, a tenere quel ciuffetto d’anarchia sparato verso il cielo a esoterica memoria del significato della libertà.
Ecco, poi tu, bambina, se ti riesce, perdonami.
Perdonami se ho smesso di cucinarti la pasta con il pesto, se ho iniziato a farmi la doccia da solo, se il mio cuore s’è girato dall’altra parte, se ha iniziato – questo pazzo schivo – a guardare più che a raccontare, se ha preso passione per le basse frequenze, dove adesso si diverte a prendere un caffè dietro l’altro seduto a un tavolino, indovinando quali battiti contino e quali no, come a segnare parole impossibili in un cruciverba di una difficoltà irripetibile; se adesso, quando gli passa in mezzo una tachicardia, si fa una risata sonora e antica, e poi si dice di smetterla e la smette.
Ti chiedo scusa se m’hanno stancato la velocità (o forse la promessa della velocità), l’altalena delle tue gambe, le smorfie della nostra disillusione. Ti chiedo scusa se non sono più capace d’esserci, se non ti vedo, se non mi ricordo più – non me lo ricordo più – dove stava la lavatrice nella nostra prima casa, e più ci penso e più non me lo ricordo (e io questo lo trovo impressionante, oltre che imperdonabile).
Scusami, se puoi, per questo fatto che non ho più parole da darti, periodi precisi per raccontare quello che mi provocava il tricipite capo mediale del tuo braccio destro. Se non mi ricordo che sapore aveva il tuo risotto – quello cotto al rovescio, ma che storia era? – l’odore della tua pelle dopo una giornata distanti, la consistenza del tuo labbro superiore; perdonami se sono in ritardo di due bimestri con le bollette che riportano nel dettaglio i kWh di luce emessi dai tuoi occhi solo per me, un lusso che non mi serve più: non le pagherò; quelli il prossimo mese chiuderanno il contatore e la cosa più triste di tutte, ragazza, è che io non me ne accorgerò neanche.
Io, ragazza, non me ne accorgerò neanche.
Ti chiedo scusa se non mi ricordo più quand’è il tuo compleanno – ci penso da martedì a questa cosa del compleanno – e dire che prima facevo finta di non ricordarlo per darmi un tono da uomo fatto, e invece adesso proprio non me lo ricordo (forse era in aprile) e neanche mi ricordo che giorno era il giorno che abbiamo preso quel caffè, con la bustina dello zucchero strappata in quarantamila pezzi tutti uguali e, bada, ci avevo riflettuto e mi ero detto: questo non te lo devi scordare. A volte è inutile rifletterci sulle cose.
Alla forma che avevano le tue ginocchia, bimba, non mi riesce più di interessarmi, di quelle ginocchia che penso fossero prodigiose – dovevano esserlo, in fin dei conti – io non riesco più a sapere niente. Il tuo profilo nel sonno, i nomi dei mostri con cui ti facevo il solletico. Non mi ricordo niente; e ti guardo, vagare per la stanza, un giro ancora, mentre cerco un disco che mi andrebbe d’ascoltare, e tu sei come impazzita dentro, come asfissiata dal tuo stesso respiro, perché tu lo sai già cosa sta succedendo. Ti prego, prendi fiato.
Dovrei parlarti qualcosa, ma la verità è che non ho più bisogno di tirare tutto fuori, sono vergognosamente capace di tenere dentro – s’è fatto spazio, lo capisci? – e questo dentro è diventato impossibile da dire. Dico tutto il resto, tranne questo. Tutto il resto posso dire affinché quello che davvero voglio dire non venga detto, ché resti qua, come un calore poggiato sullo stomaco, come una cosa luminosa che non ho voglia di spartire.
Ho trovato il disco, hai rotto un piatto. La musica parte come quella volta che t’ho incontrata per caso sull’autobus numero sette barrato, quello che portava in campagna, finché nessuno ha più avuto bisogno di andare in campagna e allora l’hanno tolto (soppresso, si dice), e c’eravamo solo tu, e io, che canticchiavo questa canzone nella mia testa – questa pazza schiva – questa musica che era la colonna sonora naturale alla scena di te che arrivavi in mezzo e rendevi questa vita una cosa più vita.
Ora c’è quella stessa canzone e non ti appartiene più, mi piace lo stesso; mi piace perché mi fa venire dei piccoli brividi lungo i polsi, sotto le scapole. Mi domando perché; mi domando anche perché succedano certe cose o come facciano tutti ad avere un’opinione su tutto (esistenzialismo, si dice), ma comunque preferisco domandarmi perché ho i brividi mentre che questa canzone va. E me lo domando.
Alla fine, praticamente all’altezza di me che vengo a parlarti sull’autobus numero sette barrato, mi rendo conto chiaramente che mi piace perché sono contento, come ero contento allora di vederti per la prima volta entrare nel mio sguardo di uomo; sono felice forse (a modo mio), perciò anche questa stupida canzone, che dovrebbe farmi piangere, invece mi fa i brividi e mi piace tanto. Alzo il volume su un numero dispari.
Scusami, bimba mia, io lo sento che vorresti urlare, andare oltre la musica, oltre il silenzio che c’è sopra, lo sento quel respiro trattenuto per sette minuti secondi (che significa che prepari un urlo) e vorresti chiedermelo, ma poi mi toccherebbe di risponderti che non lo so, io non lo so come fanno le cose che non esistono a rifarsi una vita quando qualcuno si dimentica di loro. Non lo so cosa ne sarà di te, che sei solo una meravigliosa fantasia. E sono contento che non me lo domandi, che non mi domandi chi ti leggerà i libri prima di dormire il sabato pomeriggio, chi ti porterà al cinema a vedere divertenti pellicole sui cani, chi ti prometterà una vacanza per il ponte dei morti (che quest’anno con poche ferie si possono fare tanti giorni a casa, e tu lo sai bene). Meno male che non dici niente e sopporti il tuo destino di pensiero fatto di pensieri.
Scusami, io non me lo sarei mai aspettato che mi sarebbe venuto questo coraggio di smetterla di immaginarti e di correre il rischio di venirti a cercare. No, di più. Il coraggio di smetterla di immaginarti e di correre il rischio di venirti a cercare e di giocare d’azzardo sperando di trovarti, così assolutamente diversa da come sei. No, di più. Il coraggio di smetterla di immaginarti e di correre il rischio di venirti a cercare e di giocare d’azzardo sperando di trovarti, così assolutamente diversa da come sei, e osare mettermi nella posizione di perderti. No, bastava meno.
Il coraggio di smetterla di avere paura di perderti. La musica è finita, l’autobus numero sette barrato non esiste più e non esisti più neanche tu. Nel silenzio, per l’ultima volta, ti chiedo scusa, amore mio; ecco, così, respira. Ciao.
(Illustrazione di Kaan Bagci)