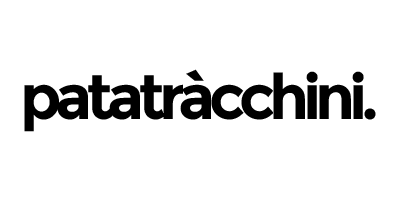16 Jan economia sentimentale.
Devo avere visto troppi film francesi, troppe di quelle pellicole che – come direbbe un amico mio – fanno una tragedia di un niente mentre che si scordano quelle altre, che sono davvero tragedie sul serio. Devo averne visti troppi e, dunque, mi capita di cercare soluzioni francesi ai piccoli problemi della non-francese quotidianità, facendo troppo spesso tragedia di un niente e scordandomi quelle altre, che sono davvero tragedie sul serio. Che volete farci?
Una delle soluzioni francesi che mi è venuta in mente per sopravvivere è stata quella, in questi anni, d’affezionarmi a un bar che sta all’angolo sotto casa mia. Mi è sempre sembrata una cosa molto francese da fare e perciò l’ho fatta: mi sono affezionata al suo pavimento chiaro e lucido, a quei residui di brioche sottili e regolari; all’assenza di posti per sedersi, a questa sua particolare scomodità. Mi sono affezionata al perimetro di questo bar, alla posizione del bancone, ai suoi caffè bruciati, ai tramezzini doppio strato, ai dolcini al limone. Ai croissant salati che, dopo un po’ di mesi, sono riuscita a ottenere che mi vengano messi – due – accanto alla tazzetta bollente e sbeccata, senza che io debba dire niente, senza che si usino parole tra di noi. Tra me e questo bar. Un legame silenzioso da svegliare presto al mattino e salvare dal freddo, da nutrire, da ripulire alla sera da tutto quello che è stata la giornata; un amore da metterlo al buio, promettendo un altro incredibile giorno da far lievitare pianissimo di notte. Una routine rotta solo qualche volta dalla richiesta di un po’ di latte montato o da un viso rammaricato che dice che oggi quella cosa che voglio non l’hanno fatta, ma – se mi sta bene – me ne danno un’altra. Mi sta bene. Le nostre piccole eccezioni, per ricordarci che siamo vivi, che esistono gli imprevisti e la fantasia: piccole anomalie a cui viene da rispondere solo oui: perché sono belle e accettabili. Il mio bar.
Mi sono abituata – perché è così che si finisce per fare – agli odori delle undici, alla signora del palazzo di fronte che compra una quantità industriale di marron glacé (al suo odore di fiori ignoranti, ai suoi polsi), alla luce del sole che batte solo qualche istante al giorno sullo specchio in alto a sinistra, agli infermieri dell’ospedale – che sta qualche via più in su – che con le loro tutine viola danno un tocco para-hollywoodiano alla faccenda, e questo rende la mia soluzione francese parecchio competitiva anche a livello internazionale.
Mi sono abituata al prezzo delle cose, a quel bisogno di calcolarlo mentre scendo le scale – ché se voglio un caffè e due brioche mi servono due euro e ottanta e io lo so – raccattando nelle tasche e tenendo strette le monete che serviranno per dimostrare a me stessa che ci ho messo dell’impegno. Mi sono abituata a quella radio a volume irrisorio, al posto dove si tiene la carta da pacchi per le paste, al livello di anidride carbonica nell’acqua gasata, ai nomi e agli occhi delle persone che lavorano, ai loro orari, ai loro umori, alla piccola ferita che hanno tutti sull’ultima falange del pollice destro: uno zigzag bianchissimo provocato dai denti metallici di un dispenser per lo scotch (che so dove sta). Ho imparato i prezzi delle torte, che vanno al chilo; quello dei cioccolatini che, invece, va al pezzo, perché vengono pesati prima, mentre che li fanno, suppongo; anche il prezzo del cappuccino so perché non si sa mai nella vita. Anche quando al posto delle solite due o tre persone, ho iniziato a trovare dentro, sempre più spesso, una confusa mandria di gente in attesa, anche a quello mi sono abituata; con il tempo anche a essere servita più in fretta, più scomoda, più inosservata. Anche vedendo le ordinazioni dei nuovi clienti crescere e ammassarsi su ogni superficie piana reale o immaginaria del mobilio, anche se certe mattine, per la fila che c’era, ho preferito solo guardare da lontano, passando, e non dire niente. Rimanere fuori e da fuori guardare l’affanno e ripromettermi di tornare più tardi, quando magari non ci sarebbe stato nessuno, quando ci sarebbe stato un po’ di posto per me. Mi sono abituata a tutto. Solo questo, un silenzioso giorno dopo l’altro in cui siamo sopravvissuti con questo senso d’oltralpe addosso, pensando che non avremmo avuto più bisogno di dire niente, più bisogno di pensare niente. Solo un giorno dopo l’altro che anche se piano piano cambiava tutto, che anche se stavamo stretti e iniziavamo a farci delle domande, ci si poteva comunque rassicurare a vicenda con i nostri caffè e le nostre brioche e i nostri due euro e ottanta. Ça marche.
Poi l’altra mattina, mi sono alzata con la fame tipica mia della mattina che è una cosa rilevante e sono scesa; sulle scale ho contato due euro e settanta nella tasca: un nervoso inverosimile. Sono arrivata davanti alla porta del bar e dentro c’era uno che tirava giù gran martellate al pavimento. L’ho fissato per diversi minuti in una condizione irrisolvibile di paralisi. Poi ho mosso lo sguardo solo per avere conferma di quanto già sospettavo: niente pavimento, niente bancone, niente paste, niente specchio, niente pizzette da aperitivo, niente torte, niente improponibili cose che chiamavamo “sedie”. Niente più.
Quello dentro deve essersi stancato presto di farsi fissare, perché ha poggiato il martello, è venuto verso la porta, l’ha aperta quel tanto da infilarci la testa impolverata e sorridente, ci stiamo allargando le cose vanno bene riapriamo il diciassette, mi ha detto. Le cose vanno bene e tu stai spaccando tutto col sorriso. Quando le cose vanno bene c’è bisogno di più spazio, c’è bisogno di chiudersi dentro e poi riaprire; e tutto s’allarga con grande dolore, con martellate fenomenali verso superfici inermi. Tutto si sposta. La ragazza dei dolci ci metterà del tempo a ritrovare quel modo inerziale per cui sapeva, senza guardare, dove stavano esattamente i budini di riso, le crostatine alla nutella, i cestini di frutta, ma lo ritroverà. Il ragazzo dei caffè avrà il suo daffare per tornare a bruciare a dovere la polvere scura. La signora del palazzo di fronte continuerà a trovare i suoi metri cubi di marron glacé: le basterà solo fare lo sforzo – per un po’ di tempo – di cercarli in giro un istante, prima di trovarli. Io accetterò il fatto che per un caffè e due brioche ora serviranno tre euro e venti e che forse addirittura ci si potrà sedere e aspettare. Noi tutti ci abitueremo a guardare anche a sinistra, in una direzione che prima non si poteva. Si potranno fare le cose che prima non si potevano fare. Io sto pensando a tutto questo, peraltro molto, troppo velocemente, e l’allegro martellatore che probabilmente vuole solo tornarsene a martellare in santa pace, ogni tanto quando le cose stanno andando bene, abbiamo bisogno di spaccare, di fare una cosa più grande, mi dice.
Ogni tanto quando le cose stanno andando bene, quando le cose stanno andando davvero alla grande, abbiamo bisogno di spaccarci, di chiuderci dentro e distruggere, di rompere tutto quello che abbiamo fatto fino a quel momento per farne una cosa più grande; una cosa che non è facile da immaginare, nascosta com’è dalla polvere e dalla stanchezza e dalla nostra benedetta fretta, una cosa così triste da aspettare già che per arrivarci ci è toccato spostare addirittura il dispenser dello scotch, una cosa così difficile da immaginare quando non sembrano esserci rimaste che le nostre macerie.
Ci stiamo allargando, le cose vanno bene, riapriamo il diciassette. Fin.
(Illustrazione di Eva Bee)