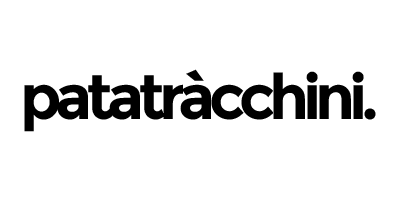19 Jul casqué.
Nella sala del tango ci sono delle regole molto precise: nessuno le conosce. Poi dopo c’è un bancone per ordinare i bicchieri di vino rosso e le birre sgasate. Dietro al bancone il barista. Dietro al barista un grande specchio corroso dagli sguardi, dai baci e dal tempo che passa. Di lato bottiglie di vetro spesso, calici vuoti, cartoline dall’Argentina. Il barista si chiama Manuèl. In fondo al bancone gracchia uno stereo a musicassette. Il maestro cambia il nastro ogni due ore. Nella sala del tango c’è il maestro. Il maestro è uno che sa cosa fare. Balla con tutti, ben attento a non legarsi a nessuno. Se è un bravo maestro, alla fine, tutti balleranno e lui invece rimarrà da solo. Questa dovrebbe essere una cosa che lo rende soddisfatto: così ha avuto un senso. Finisce sempre che resta un poco triste, ma non lo dice a nessuno. Ai bordi della sala sedie nere, in fila, come ciglia colpite dal rimmel sul limite dello sguardo d’una donna bellissima. Seduto sulle sedie c’è chi aspetta. Aspetta. Aspetta che qualcuno lo inviti a ballare. Qualcuno che avrà certamente i capelli nerissimi. E aspetta. Inès aspetta da venticinque anni. Ancora, c’è chi balla con la stessa persona da cinquant’anni. Una noia dolcissima senza volontà di perfezionamento; una noia dolcissima tenuta su dal cadenzato desiderio di ritrovare sempre gli stessi errori al loro posto. Gli errori sempre uguali che ci rendono chi siamo. C’è chi beve solo al bancone, chi parla della sua giornata e viene a guardare gli altri che ballano. C’è chi s’è appena conosciuto e balla forte, le ore, di modo che il corpo si sciolga di sudore e ci si possa odorare, evitandosi – per riuscire a conoscersi sul serio – dieci anni di parole inutili. C’è chi è uscito un attimo, e non è tornato più. Quando entri nella sala del tango, ti tocca di trovarti un posto. Prendi me. Io pensavo ci si andasse solo per ballare e stare sempre in due, che quello era il modo per essere felici. Poi, una volta dentro, per ballare non ho trovato nessuno. Una tristezza. Una delusione. Da sola, allora, mi sono trovata delle cose da fare. Ho fatto spola, per lungo tempo, dall’ultima sedia di sinistra, dove me ne stavo seduta a aspettare, al bancone di Manuèl, dove ho bevuto da mille bicchieri diversi, conosciuto tanta gente, parlato in migliaia di lingue. Ho iniziato a star bene, e a pensare che forse una delle regole sconosciute della sala del tango fosse che anche soli si potesse sentirsi parte di quello che accadeva, si potesse forse anche imparare a godere l’attesa, riempiendola di meraviglia. Che forse era quella la felicità. E andava bene così. Ma le regole della sala del tango sono davvero sconosciute. E una sera, che io già mi stavo divertendo forte e andava tutto bene, tu sei entrato: goffo, sorridente e spettinato. Non hai detto una parola. Mi hai cercato tra le facce. Mi hai guardata. Mi hai preso la mano. Mi hai portato a ballare. E ci siamo sorrisi e baciati le spalle. Abbiamo ballato malissimo, io e te, ma non abbiamo smesso nemmeno per un attimo. E uno potrebbe pure pensare che quella sia la felicità. E invece no. Bada, quello è un miracolo. Io e te – che abbiamo ballato malissimo per tutto il tempo che le gambe c’hanno retto – siamo un miracolo. La felicità è tutto quello che c’è stato prima e tutto quello che ci sarà dopo. La felicità sono tutte quelle notti, un tempo verbale in cui tu ci sei sempre stato e non ci sei stato mai, una declinazione in cui non sarai mai esistito e ci sarai per sempre. La felicità è non aver più paura che tu vada via. Però, ora basta. Vieni qui. A tempo. Casqué.
(Illustrazione di Harumo Bakery)